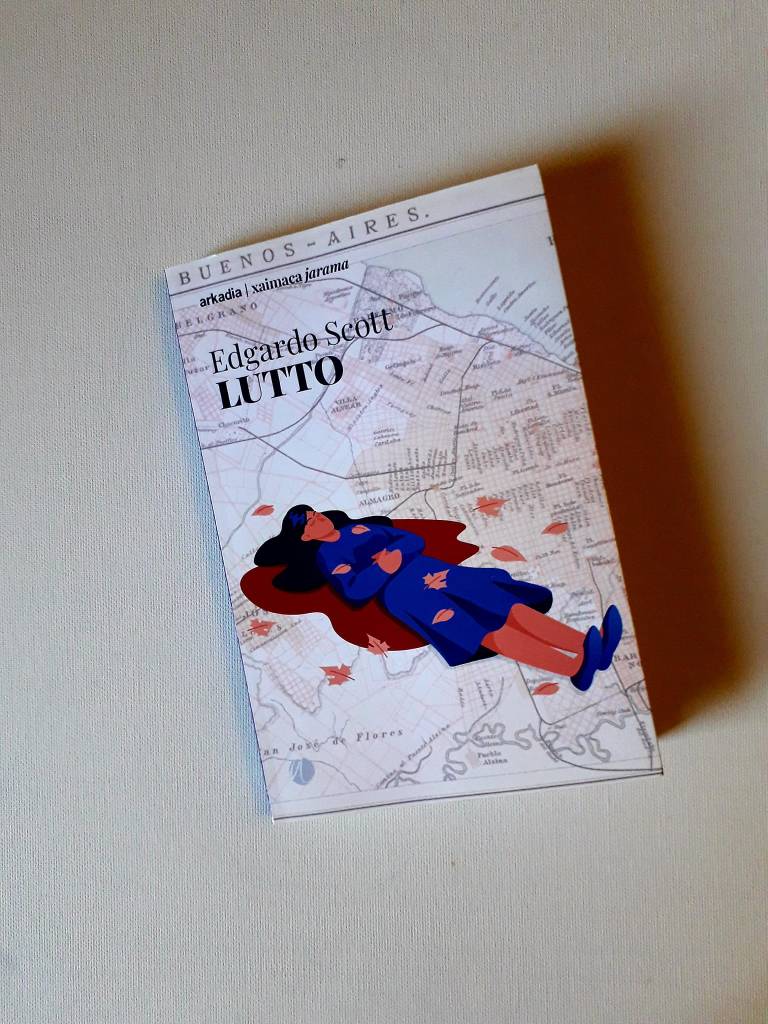
Il libro di Edgardo Scott (Arkadia editore), oggi ospite su Ork, lo sintetizza perfettamente, nella nota finale al testo, il suo traduttore per l’Italia. Alessandro Gianetti sofferma la sua attenzione su un’abitudinarietà dell’agire che si radica ostinatamente su un tentativo di eternità possibile, mentre parallelamente il tempo fa il suo corso all’interno del proprio quartiere concepito come “nucleo essenziale, cellula protettiva di un’esistenza altrimenti troppo dispersa per essere raccontata o semplicemente vissuta”. È la periferia di Buenos Aires, in effetti, uno dei punti cardine della narrazione, non solo in quanto ambientazione della vicenda, ma anche quale spunto di riflessione in merito al mutamento di una società che sacrifica l’infanzia, la convivialità, lo scambio sano nella dimensione del vivente, lo spazio verde, l’equilibrio idealistico-pragmatico del genere umano, oltre che quello che lo pone in relazione con l’altro, animale o vegetale che sia, in nome di una produttività fine a se stessa, del profitto, della sicurezza, della negazione di ogni forma di utopia residua. Non è casuale che un personaggio tutt’altro che rivoluzionario si muova su questo sfondo che, nel corso del tempo narrato all’interno del romanzo, non rimane uguale a se stesso, ma muta profondamente in funzione delle logiche di potere che ribaltano le ingenue esigenze di una comunità persa in una storia lontana almeno quanto la fatica del protagonista di vivere nel presente: quello che, di volta in volta, quasi l’oggetto senza identità precisa di uno sguardo rivolto all’esterno da un trasportatore virtuale, si sostituisce all’idea di un passato in cui, pure in una parziale aridità di scelta, c’era spazio per un margine di affettività e sopravvivenza di valori umani.
Il romanzo si apre con un’abitudinarietà interrotta e, potremmo dire, si chiude al medesimo modo: quasi una circolarità che si compie perfettamente lungo un percorso in cui il ripetersi estremo di una serie di azioni celebra il tentativo quasi drammatico del protagonista di resistere all’abisso del dolore che fa precipitare inesorabilmente verso la fine in una velocità temporale che qui non si conosce. Questo perché qui tutto è quasi fermo o, meglio, lo è tutto ciò che investe la vita di Chique il quale non trova altra possibilità di sopravvivere all’uccisione della moglie, avvenuta nel corso di una rapina ai danni del loro negozio di elettrodomestici, che negarsi al dolore della sua scomparsa. È entrare nella sua dimensione che produce l’interruzione ordinaria dello scorrere del tempo e il blocco di una possibile avanzata del futuro: non esistono sogni nella terra di Chique, ma solo la prova di una sicurezza violata e l’ostinata volontà di ripristino di ciò che ha infranto l’abitudinarietà rassicurante dentro cui viveva prima che la vita si premurasse di distruggere l’impianto mentale di una serenità dove non c’è altro modo per stare al mondo che vivere nei margini angusti dell’umanamente prevedibile.
A ben guardare, la scelta della negazione dell’esperienza del dolore è preparata, anticipata dalle prime pagine del romanzo di Scott, poiché non esiste ab origine la rappresentazione di un idillio, di una realizzazione umana, di un sogno calato nel reale che il trauma di una morte spezza generando il facile precipitare nel nulla, nell’insensatezza, nel vuoto: l’aridità che subentra nella resistenza all’esperienza del lutto è certamente un’imposizione rivolta a se stesso in funzione di un’autotutela che preserva dalla disintegrazione o dal rischio di condurre nel nulla l’unico barlume di futuro che si affaccia nella sua vita e che la figlia incarna in un’evoluzione che la spingerà fuori dalle premure castranti del padre, ma non è soltanto questo. Essa è come se si ponesse quale sbocco necessitato a un’esistenza in cui l’immensa felicità può essere la derivazione di un possesso, ci piace qui chiamarlo, o l’illusorio margine di una vita che potrebbe essere, ma non è, come fosse quella di un film al cinema: in sostanza, ad esempio, l’inebriante fluttuazione della propria stabilità provata per l’avvento dei videoregistratori che gli offrono, pur nell’applicazione di regole di contenimento, quali la domesticità, lo schema, la routine, il metodo e l’abitudinarietà di un limite massimo della visione di uno o due film a settimana, un sogno limitato alla loro durata e, pertanto, gestibile, un travolgimento che termina con la chiusura della visione, la conoscenza di una fragilità che non confuta il proprio sesso (“Senza esserne del tutto consapevole, Chique è interessato ai film in cui viene messa in gioco la virilità. Film in cui è presente un eroe o un antieroe maschile. Uomini deboli o forti, ma che realizzano un destino o che ne sono travolti”; “Sì, a Chique piacciono film come Revenge, film in cui gli uomini affrontano i loro fantasmi, le loro debolezze, la loro condizione: il coraggio, il tradimento, il valore, la vigliaccheria. Anche Chique, dopotutto, è un uomo.”).

Perché, se il dolore, con i suoi effetti vorticosi e risucchianti verso un punto che tremola a ogni sospiro, reca con sé il rischio di una scomposizione, anche preservarsi dalla felicità è un’analoga forma di difesa: in fondo, potrebbe “solo” trattarsi di un agire in anticipo, di una strategica scelta di prevenzione rispetto alle spire del dolore. Chique rifiuta la complessità dell’esistenza: in fondo, “è sempre stato molto abile come meccanico e come elettricista. Assemblaggio, smontaggio e riadattamento dei pezzi. Ha sempre capito molto bene i sistemi chiusi, la logica onesta dei meccanismi”. L’umano, però, fuoriesce da tutto questo perché si compone di una percentuale di imprevedibilità rispetto a cui il ricorso estremo alla sicurezza quale sistema di vita può solo nei limiti in cui inganna il nostro bisogno di credere di avere un potere, oltre il possesso, sulle cose, incluse quelle che decretano il taglio del filo che ci sostiene nei nostri illusori ruoli quotidiani. Ci si attacca alle cose, senza sapere a quale scopo o il motivo, alla certezza che paiono garantire, si rimane fedeli ad esse, si confondono consistenze e identità, cose e persone e una figlia finisce per essere “come un bene, una proprietà che quanto più è calma, vicina e sicura, meglio è”, si tentano relazioni con l’altro sesso in una logica pragmatico-utilitaristica e, in quanto tali, si praticano solo se non offrono accenni o speranze d’amore. Finiscono i sogni nei cortili delle periferie, finisce il sogno possibile di una rivoluzione che, impasto di ideali e necessità, muove e scuote il mondo del progresso a oltranza. Gli animali sono quello che restano dei nostri scempi, le carcasse che investite dall’uomo resistono per le strade quale prova dell’incomunicabilità fra il vivente, sono quelle che Chique fa bruciare insieme alla spazzatura in un rito settimanale di cancellazione che, insieme a tutte le sue abitudini, non lo porta avanti, ma neanche indietro, a rivivere il passato, preservandolo in una stabilità, seppur faticosa da eterno presente, sono quelle che, unitamente alla scomparsa degli ombù, racchiudono quello sguardo che, fuori dalla vita del protagonista, offrendoci l’opportunità di un confronto con il procedere del mondo, è idoneo a farci comprendere, nel concreto, il mutare del fuori, nonostante l’ostinata e parossistica fermezza di Chique.
Potrebbe il romanzo di Scott essere esclusivamente la celebrazione della fine di un’epoca narrata in uno stile che, volutamente impersonale, si pone quale specchio perfetto di un sentire interrotto e che, pertanto, rende quasi accettabile e ordinario un vivere che è uno schema eternamente ripetuto: ci si adatta e ci si adagia, eppure non si rinuncia a credere in una svolta, come se un qualche sotterraneo rivolo di un lontano passato salisse su in qualche piccolo anfratto a mantenere fertile il terreno di un sogno lontano. Miguel ne è l’esempio più completo e, probabilmente, volutamente più esteso per contrapposizione a Chique: “Miguel non è ottimista, al contrario, ma Chique non sa che Miguel metabolizza e trasforma il suo pessimismo in un atto di misericordia e comprensione”. Miguel è ciò che Chique non è: l’espressione di una compenetrazione nel vivente che gli regala quello sguardo oltre, sugli uomini e le cose, che non elude il dramma, che a un certo punto si compie, ma lo rende l’unica scelta possibile di fronte a un mondo, collettivo e personale, in frantumi. Miguel è l’amico ubriaco, latore di una verità destinata ad essere inascoltata, una sorta di “fauna acquatica, un’idilliaca barriera corallina dove i pesci si divorano a vicenda e generalmente il più grande – il più forte – divora il più piccolo, il più debole”. È quello che resiste all’opportunismo e alla disumanità crescente, quello che non si fa annullare da un mondo che non gli somiglia più neanche un po’ e che sceglie di andarsene quando il filo che lo ha generato, nelle oramai mature fattezze materne, si spezza per sempre. Incapace, perché ingenuo e fragile sognatore, di opporre al mondo una propria verità attraverso la costruzione di un nucleo resistente, soccombe, senza però cedere al cinismo e benedetto da una pietas che il protagonista scarta investendo di rabbia e della forma zingaresca tutto quello che sfugge alla conoscenza e al controllo. Romanzo estremamente sincero, quello di Scott, per quanto si possa dire di un’opera di fiction, qualità non particolarmente diffusa negli scrittori contemporanei della sua generazione che, pur nell’evidenza di un talento, cedono a cliché e stereotipi, rinunciando implicitamente a un’originalità che qui è pienamente compiuta, unitamente all’evidente padronanza di un territorio che l’autore sceglie di indagare senza furbizia, evitando di sfiorare ciò che non gli appartiene o non gli appartiene ancora.
Mindy